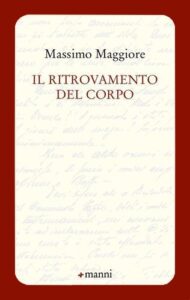Il ritrovamento del corpo di Massimo Maggiore (Manni, 2024) si apre con alcuni appunti per una teoria del corpo:
Anima antropomorfa. Topografia dell’indecifrabile e suo sovvertimento.
A sua immagine e somiglianza, non è possibile fuoriuscire.
Quando il narratore si allacciò le scarpe, finalmente pianse la nonna morta.
Forse gli serviva sentire il fastidio della fibbia sulla bocca dello stomaco.
Tagliamo il glicine dalla strada, ostruisce il passaggio.
Scegliere tra le facoltà del camminare e quelle del guardare.
Inquinamento dell’innocenza.
Aveva un’amicizia annodata di sentimento che i sensi oleavano.
Da questi appunti ne nascono ipotesi e poi tesi che portano come prove esperienze corporee sensoriali vissute in prima persona, riemerse dai ricordi e avvertite nel presente, per poi di nuovo abbandonare un corpo deperito, che si fa di nebbia.
Nel primo capitolo, dal titolo “Vita involontaria”, Massimo Maggiore ci ricorda di essere onesti con noi stessi: occorre che smettiamo di pensarci al mondo per un volere superiore, per il “miracolo della vita”, o per qualcosa di elevato.
Più che essere creati a somiglianza di Dio, siamo delle sementi incoscienti, programmati per radicare e crescere. Le vite di un seme, di un pesce, o di un uomo sono determinate da lunghe catene proteiche, sono un continuo metabolismo che si ripete sino alla morte, sono chimica organica.
L’homo sapiens cerca di evadere dall’insensatezza dell’automatismo per mezzo del libero arbitrio. Vuole lasciare un segno, pur modestissimo:
Dai, imprimiamo questo nulla
facciamone una lastra
ai sali d’argento
che nel nulla si intraveda
il nostro passaggio.
Ancora si avverta
il nostro giro intorno al vuoto
presi per mano
dai lembi del tardo pomeriggio
quando comincia a derubricarsi il giorno
a stingersi nel buio
la nostra radiazione di fondo
ché l’impressione
verrà presto sovrascritta
e di noi resterà comunque
l’aria cambiata.
Nonostante il nostro vivere possa impressionare appena una lastra grigiastra ai sali d’argento e far circolare un po’ d’aria, avvertiamo l’incombenza di dare seguito alla nostra specie.
È un’incombenza – di nuovo involontaria – quella di sedurre, come è involontario per un pruno mettere dei fiori, affidare il polline al vento, agli uccelli, agli insetti, e poi fruttificare.
È in questo modo che si avvera l’ereditarietà: nel solco della tradizione familiare. Noi cresciamo, invecchiamo, produciamo altra prole, come hanno fatto i nostri genitori. Nella zona di comfort di un programma già scritto si sospende l’esercizio della consapevolezza:
Sono pignoli aguzzini della
consapevolezza, a modo di tralci
prescritti dalle spire di un istinto
che tira giù le gambe,
le appesantisce.
Prendere coscienza del vincolo familiare, della spinta alla vita e alla riproduzione, è una riflessione faticoso. Forse l’autore ne ebbe un primo sentore sin da quando avvertiva la fatica della nascita e della crescita, quando:
la pelle si formava,
le ossa del cranio erano piattaforme di continenti
alla deriva, in attesa di richiudersi
a inscatolare l’anima.
Abbiamo il punto di vista di un neonato, il cui sguardo non vede quasi nulla, ma con l’espressione di chi sa già moltissimo. La sua conoscenza pervade tutto il corpo. È tutto il corpo.
Con la crescita fisiologica e poi con l’educazione, queste due entità di corpo e mente prenderanno due sedi distinte: il pensiero avrà luogo nel cervello, nella scatola cranica, e il corpo occuperà tutti gli altri tessuti, realizzando la distinzione platonica tra anima sovrasensibile e corpo sensibile.
L’uomo e la donna adolescenti sono indotti ad accettare questa distinzione, imparano a farsi guidare dalla ragione, a “ragionare con la testa”, sovrastando gli stimoli dei sensi, come se il buono nascesse dalla testa e l’animalesco rischiasse di manifestarsi in modo inopportuno ad un richiamo ancestrale dagli organi di senso.
L’io lirico a questo punto decide di fare un passo evolutivo all’indietro per recuperare la sensibilità: lascia fare al corpo e di questo si fida.
Le citazioni in esergo al libro già prefiguravano questa scelta:
Io non ho ma sono il mio corpo
Roberot Esposito, Le persone e le cose
L’esistenza mi penetra da tutte le parti, dagli occhi, dal naso, dalla bocca…
Jean Paul Sartre, La nausea
E lo sguardo che si guardava
L’udito che si udiva
L’odore che si odorava
Il gusto che si gustava
Il tatto che si tastava
E il sesso
Giovanni Giudici, Gli oggetti interni
L’autore in questa raccolta ritrova il suo corpo e con esso esperisce il mondo a partire non dai sensi più raffinati, educati, analitici. Non è un apprendimento a distanze medie e lontane, è un apprendimento ravvicinato, al millimetro, richiede presenza e contatto, richiede i sensi della prossimità: il gusto, il tatto, l’olfatto.
Le poesie in “Il ritrovamento del corpo” recuperano moltissimi odori, non tutti piacevoli: il profumo degli agrumi e dell’aria sporca, un odore acre e cattivo, l’odore del letto, di tabacco mischiato a muffe, un odore forte di lanolina e di corpi uccisi in guerra, il profumo immaginato di una rosa.
La pelle è protagonista del senso del tatto, viene proposta in molte le declinazioni: la pelle è escoriata o graffiata, è la pelle delle labbra, è il cuoio usato e verniciato, sono squame di acciughe, la pelle è rigenerata o nuova come quella di un neonato.
Tutto questo sentire è spesso vettore di ricordi di quanto fu avvertito nel passato.
Quando si pensa alla memoria olfattiva e gustativa in letteratura, è facile ricordare Marcel Proust e le sue madeleines. Massimo Maggiore è infatti un profondo ammiratore di Proust, e de “La Recherche” fra tutte le sue opere.
Anche l’autore si dimostra in grado di riconosce per istinto quando si ripresentano le sue madeleines, e da queste si fa trasportare nella memoria sensoriale, perché ha imparato a ri-fidarsi delle sensazioni che ri-affiorano per mezzo del corpo ri-trovato.
Questa è un’altra delle qualità migliori che si possono trovare in un poeta: saper restituire in versi l’esatta sensazione di un istante.
Ciononostante, Maggiore confessa di sentirsi sempre sguarnito delle parole esatte per trasmettere al lettore la sua percezione:
Si può distinguere il canto di un uccello dall’orecchio che lo ascolta? La dimensione poetica si realizza a due alla volta e non esiste poesia se non vi sia anche un corpo diverso in cui risuoni. Ci vorrebbe la singolarità assoluta.
Ogni inclinazione d’animo, le diverse gradazioni della luce, i secondi del giorno dovrebbero avere ciascuno un nome proprio. Un essere disperso residente in voci momentanee. Il poeta è un’identità diffusa.
Non si può avverare tra i denti
se non il cibo che si è stati.
Lo schiocco
di corpi contro altri corpi
è il suono del mondo.
Non c’era alcuna ragione perché esistesse
questo dilatarsi e restringersi del torace
ma non era possibile non esistesse.
Hanno passato un legge
e sospendono gli anni.
Ho fatto domanda, è stata accolta.
Girato l’angolo del palazzo del Governo
ho rivisto il compagno delle medie
con la bici trattenuta tra le ginocchia segnate
chiede se ho risolto l’espressione coi monomi.
E se svoltare gli angoli di antichi
palazzi, se fosse tutto lì il senso
del tempo?
Fino a quando esiste
un corpo
esiste un invito a cena.
La casa è del suo corpo vitale,
la sua voce dice quel
che pensa,
la sua lingua si disseta.
I suoi occhi hanno da tempo capito
come a Scorsese piaccia
fare film in cui si muore solo
per mano degli altri.
Sta sulle gambe in piedi
la sua noia, accennano
un passo di fuga
quando la musica anni ’80
– si dice – abbia lasciato
un alto fossato
tra i ‘70 e i ‘90.
S’aggiunge il corpo ai corpi
giunti alla fine del corridoio
s’aggiunge il corpo a parziali
essudazioni d’altro che non è corpo
allo strabismo di un’ospite
che moltiplica possibilità
sugli occhi incatturabili.
Senza più corpi a breve
la stanza tornerà inattesa
rimarrà il nulla provvisto di spazio.
Elisa Malvoni