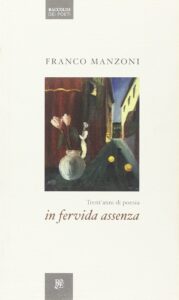«tuoni distonie nel vento / momento di sonorità di suoni / sull’arte scossa della fuga / musa smossa dal suo nero antro […] sai / piano migranti / sbancano il confine / in fervida assenza». Trent’anni di poesia, trent’anni che Franco Manzoni racchiude in una silloge complessiva (Franco Manzoni, in fervida assenza, Trent’anni di poesia, Raccolto Edizioni Poesia, Milano, 2011, pp. 175), in cui si delinea come in una sequenza di immagini e parole e suoni un percorso lirico ed esistenziale. Trent’anni in cui Franco Manzoni, voce poetica limpida e forte, traduttore dal greco e dal latino, paroliere, critico letterario, autore di programmi Rai e firma storica del «Corriere della Sera», attraversa il tempo dal 1978 al 2010, dando spazio e forma ad una poesia che racchiude lo scorrere di un’esistenza, il fluire di un sentire che si pone quale punto di raccordo per nuovi assetti e passate esperienze. Un volume pressocché completo, arricchito da diciassette illustrazioni di Daniele Oppi, con ampi spunti critici a firma di Roberto Mussapi, Gilberto Finzi, Alberico Sala, Carlo Alessandro Landini, Roberto Sanesi, Matteo Collura, Vincenzo Guarracino, Guido Oldani, che rappresenta la summa lirica del poeta milanese, fondatore e direttore responsabile della rivista di cultura e poesia “Schema” e figura di spicco del panorama culturale del nostro tempo.
Una poesia di inappartenenza, quella di Franco Manzoni, che nasce e scorre cristallina come un fiume, risuona nitida nel suo incedere ma esplode e si inabissa nella deflagrazione della corrente, permane nel silenzio e poi sbiadisce in tanti cerchi concentrici, nell’inchiostro della incorporeità della presenza, una poesia che è come un fiume sotterraneo che tuttavia continua il suo percorso verso il mare: scorre, nel silenzio e nell’impeto dell’accelerazione, si inabissa, cresce e si dipana, negli antri del dolore e dell’inconscio, ma pure riaffiora in superficie e sgorga nuova e limpida, fecondando tutto. Una poesia di amori muti e assenze presenti, dunque, d’un sentire alto e scanzonato, veloce e piano, fatto di stanze che non si abitano più, stanze provvisorie, come certi luoghi antichi, ripercorsi dal poeta attraverso la vocalità gestuale della parola, attraverso la cinetica del ritmo del verso, capace di dare voce al vuoto, o meglio ad una parola che sa ciò che si è amato e tutto trattiene: «uguali appartenerci un po’, per pochissimo» (Di abitarti, in “Stanze d’argilla”, p. 61), nella provvisorietà transeunte della transitorietà umana e della vita: «le stanze sono vuote non sono / case fresche di calce che canta […] le stanze non sono / sono vuote / aria». Gabriella Sica, in Poesie d’aria (Interno Libri, 2021), sublima attraverso il canto una presenza fatta d’aria, che si ammanta del ricordo e della poesia, ma Franco Manzoni va alla ricerca del perduto fino a dare corpo, nella strutturazione fonica e ritmica, all’assenza: «alle spalle ti sento / miele morbo / così sei / la fàtica assenza / qualcosa / turbamento / una sostanza / incerta / il giocattolo / quella pianista / che concede / un eccesso di bis / nella sala / deserta» (L’assenza, in “Stanze d’argilla”, p. 62). La fatica assenza, dunque, con una risemantizzazione lirica del termine che viene assunto qui nel suo valore evocativo, in un ribaltamento di quelle strutture logiche e periodali a vantaggio di una logica poetica che, come evidenziato da Lacan, fa sì che sia la parola stessa a dare senso al suono, la fatica dell’assenza, o meglio, una assenza che si dice, fàtica appunto, che si rivela, autonomamente, che lascia sempre una sospensione, un non essere mai, che dilania e seduce, in attesa di quel suo farsi da sé, sempre come mancanza, bisogno, dolorosa aspirazione, disappartenenza: «sillaba…serva di Dio», «il figlio sperso», «il mio fiume in letargo», «ibridandosi». Una poesia di amore e morte, quella di Franco Manzoni, in cui la grazia limpida della parola s’ammanta di stupori e meraviglia, si frantuma in versi franti e scomposti, capaci di «un’espressività ermetica che tuttavia si tinge di una vena quasi barocca» (Carlo Alessandro Landini), in cui l’alternarsi di periodi strofici volutamente discontinui e versi che indugiano al silenzio, fa sì che il recupero della tradizione (dai suoni latini al gusto greco- alessandrino per l’aggettivazione vivace) a certi sapori pascoliani e della linea novecentesca e lombarda, siano il presupposto di una ricerca poetica che si fonda su un nitore espressivo e su una musicalità verbale che coincidono con una rinuncia alla significazione comunemente intesa: l’esperienza della perdita, come in Faccina o in Esausto amore, genera una poesia che nel recupero memoriale affoga lo strazio della fine e lo riattualizza in un processo creativo sempre vivo, sancendo, in fervida assenza, una condizione esistenziale come sospesa, ossimorica e tuttavia mai acerba, dimidiata eppure bisognosa di amore, interiorizzata e dunque, eternamente presente. È il dolore, come l’amore, il fiume che scorre subitaneo e sotterraneo nella lirica manzoniana, che ogni tanto riaffiora ed esplode e s’acqueta ma è onnipresente, verso dopo verso, fino al raggiungimento del silenzio, della pausa, della dignitosa commozione, della composta disperazione, della compassione. È nel fragore della vita e della rima, la verità della perdita e l’indagine, il dramma tutto umano dell’esistenza, in un rapporto dialogico con il reale e con quell’ “altrove” imaginifico e consolante che solo la costellazione fantastica della parola, capace di risemantizzare il ricordo e da qui il presente, può generare, nella lingua sempre viva della poesia. Una poesia che si origina dall’esperienza della morte e del dolore, ma che sa farsi canto di vita e di bellezza, un canto fervido alla presenza, costellato da memorie imperiture e affetti indelebili, un fiume non umbratile ma alcyonico, che scorre sempre verso il mare, verso la meta e il richiamo, il sogno e il ritorno.
Laura D’Angelo
Opere e giorni
scrivo sommerso da ricordi irraggiungibili
nastri di compleanni srotolati invano
occasioni divorate dal veloce andamento
dai secondi che vanno di continuo a cancellare
le attese parole in un silenzio fondo mare
(Da Cantico della creatura, p. 156).
Sdraiato
da una casa all’altra
sdraiato su tapis roulant
senza che una casa nessuno
mi appartenga
paesaggi che crepano veloci voci
autostrada treni casellanti
solo gli orari chiusi nelle orecchie
profilo mentale eccellente
un fuggi fuggi
trapela lo sgomento
dove arrivare e vomitare in fretta
(Da Figlio del padre, 1999, p. 129)
Il mio fiume
scorre sereno largo
il mio fiume in letargo
il Po gigante disteso
riflesso di un cielo teso
nel silenzio più arreso
nel più ampio dolore
non placa l’aspro peso
di una figlia che muore
mi sto zitto
claustrale
nel cuore ho fitto
mille e uno strale
l’acqua eterna procede
mi ride piano sale
a placare la sete di fede
non ho più male
(Da Nel temperamento disequabile, p. 148)